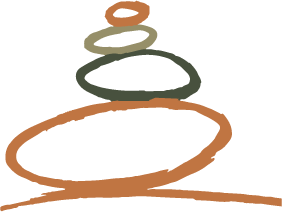È sera non troppo tardi, trovo posto per la macchina nel parcheggio del piccolo centro commerciale vicino casa. Scendo e noto un gruppo di una ventina di ragazzi a poca distanza da me. Loro non sembrano accorgersi di me, continuano a chiacchierare, a ridere, scherzare e farsi i fatti loro. Io mi irrigidisco, il torpore di fine giornata sparisce, sento una nuova lucidità e un’improvvisa attenzione, percepisco l’ansia che sempre più forte mi urla nella testa “stai all’erta!”. Perché? Perché gli adulti sono portati naturalmente a temere gli adolescenti o, se non altro, ad essere preoccupati per loro?
Come molti altri, ho visto la nuova serie Netflix “Adolescence”, che segue le vicende di un ragazzo di 13 anni accusato dell’omicidio di una sua compagna di scuola e le successive conseguenze di tutto ciò. L’ho trovato un prodotto ben scritto, ben pensato e ben furbo. La scelta di regia di utilizzare un piano sequenza (una ripresa fissa unica senza tagli tra una scena e l’altra) per ogni episodio non lascia possibilità allo spettatore: per quattro ore lui deve stare lì, completamente esposto alla narrazione, tanto quanto Alex (il giovane protagonista del film “Arancia Meccanica”) quando viene sottoposto al “trattamento Ludovico”. Nel prodotto di Netflix tuttavia lo shock non viene ottenuto tramite l’esposizione diretta all’episodio violento come fatto nel trattamento “medico” ipotizzato nel film di Kubrick (l’omicidio in sé viene velocemente fatto vedere nel primo episodio e poi mai più) quanto piuttosto tenendo la camera spietatamente puntata a riprendere le reazioni e i comportamenti di tutte le persone coinvolte dai fatti. Non c’è pianto, disagio, urlo, scatto d’ira o momento di fragilità che venga nascosto: tutto è lì, sotto i nostri occhi, dalla confusione degli adulti alla rabbia scomposta del giovane protagonista. Il risultato, almeno su di me, è simile a quello ottenuto per Alex Delarge: concludo l’ultimo episodio con un senso di nausea, impotenza e rifiuto. Tuttavia, mi rendo ben presto conto che non so bene nei confronti di cosa io stia provando queste sensazioni.
Leggendo in giro ho notato che generalmente tutte le recensioni e analisi sono concordi nel lodare la serie per le tematiche che si è scelto di trattare: i concetti della “redpill” e del mondo degli “incel”, la mascolinità tossica e l’effetto totalizzante dei social nella vita degli adolescenti. Tematiche molto attuali e dibattute nella vita reale ma che risultano ancora nuove e d’impatto per il mondo della fiction e della serialità televisiva, soprattutto main stream. Non sono sicuro tuttavia che siano state queste tematiche a scatenare questa reazione in me.
Il titolo della serie non è “Incel” o “Toxic” (sottintendendo alla mascolinità tossica) ma “Adolescence”: il titolo è la prima cosa che conosci del prodotto e la prima cosa che la serie vuole dirti è che si parla di questo, di adolescenza e giovani. Nella seconda puntata c’è un momento che ai miei occhi (e a quelli di altre persone con cui mi sono confrontato) appare vagamente fuori luogo: uno dei due agenti che indaga sull’omicidio (la donna, il personaggio con meno battute della serie) si rammarica del fatto che di tutta la storia alla fine ci si ricorderà solo di Jamie, l’aggressore. Bene, bravi, giusto, ma allora dov’è l’episodio su Katie, la vittima (ricordavate il nome)? Dov’è il suo punto di vista, la sua esperienza, quell’ora in cui mi costringi a stare con lei? Netflix definisce la serie come dramma, ma nel suo episodio più lodato (il terzo) le dinamiche sono da film horror: Jamie è imprigionato ma in controllo, fa paura alla psicologa e fa paura a noi che vediamo i suoi comportamenti. Pensandoci ora che scrivo, sono dinamiche e situazioni che ho già visto da qualche altra parte, compreso il sussulto spaventato di una psicologa femminile di fronte a un assassino in prigione: la prima scena in cui Clarice Sterling incontra Hannibal Lecter ne “Il silenzio degli innocenti”. Sopra ho parlato di prodotto furbo e questo è forse il motivo principale: le tematiche di cui sopra non sono analizzate quanto piuttosto sono utilizzate, tanto quanto un film horror non analizza il problema della violenza e invece la usa per fare paura. Il titolo della serie non è neanche “Jamie” perché non è lui il protagonista: è un involucro, un simulacro simboleggiante l’adolescenza tutta, un mondo misterioso e pericoloso, così oscuro e alieno per gli adulti, che ipotizzo essere stati i principali fruitori della serie. Nelle puntate stiamo sempre con qualche ragazzo ma la telecamera funge sempre come occhi di qualche adulto: i poliziotti, la psicologa, il padre. La serie parla quindi di adolescenza ma lo fa pensando agli adulti e questo non si può certo dire che sia una novità nel cinema o nella televisione, così come non si può certo dire che siano innovativi i colori emotivi scelti per trattare questo tema: ancora una volta l’adolescenza è grigia, cupa, rabbiosa, incomprensibile.
Faccio fatica a ricordare prodotti narrativi in cui l’adolescenza non sia stata trattata in questi termini: da “Gioventù bruciata” a “3 metri sopra il cielo” la dinamica dei prodotti che ricordo è sempre la stessa: caos, turbolenza, ribellione violenta. Un’eccezione che mi viene in mente si chiama “Big Mouth”, un altro prodotto Netflix che si prende molto più tempo e tratta (qui per davvero) le stesse tematiche, ma con molta più leggerezza, senza sentire il bisogno di spaventare lo spettatore. Non a caso la serie è animata e colorata e da molto più l’impressione di essere pensata con in testa un’idea di spettatore giovane.
Molti adulti che ho letto nelle loro analisi o con cui ho parlato di persona hanno detto la stessa cosa: dobbiamo fare attenzione, non ci stiamo capendo niente. Ma quale generazione di adulti ha capito la propria generazione di adolescenti? Il faticoso (per noi adulti, gli adolescenti già lo sanno) dato di fatto da masticare e metabolizzare è che forse è proprio così che la crescita è destinata ad andare. L’adolescenza è un momento di passaggio per definizione: né adulti né bambini, ci si inizia a confrontare con il mondo con maggiore autonomia e indipendenza senza tuttavia avere ancora tutti gli strumenti a disposizione (sociali, culturali e biologici) per capirlo, navigarlo e dominarlo. È il momento in cui le sicurezze crollano e vengono sostituite da dubbi, domande, perplessità. È il momento in cui si scoprono tutte le menzogne degli adulti: non è vero che andrà sempre tutto bene (o che andrà sempre tutto male) o, nel caso del protagonista di “Adolescence”, non è vero che piaccio a tutti e “sono ok” secondo ogni standard, per utilizzare il linguaggio dell’Analisi Transazionale di Berne.
Il compito dell’adulto non è mai stato quello di capire: chi è adulto è chiamato ad essere presente, pronto ad accogliere tutto quello che l’adolescente porterà. Loro hanno diritto alla loro paura, che poi un tempo è stata anche la nostra. Ma noi ora siamo dall’altra parte della tempesta mentre loro sono ancora nel mezzo, è il loro momento ed è importante avere la forza necessaria per lasciarglielo vivere liberamente.
Mi fermo un secondo nel parcheggio e tengo lo sguardo sui ragazzi in lontananza. Sento la tensione sciogliersi, le gambe tornano morbide. Mi allontano, penso alla settimana che verrà, ai pazienti che incontrerò, giovani e adulti.
“Anche nel peggior carattere c’è il 5% di buono. Il gioco consiste nel trovarlo e quindi nello svilupparlo fino ad una proporzione dell’80% o 90%.” Baden Powell, fondatore dello scoutismo, il più grande movimento di formazione ed educazione giovanile del mondo.